Sparare ad Ardenzi?
Giorgio Tirabassi, approdato alla scuola di Gigi Proietti nel 1982, dove ha studiato per 9 anni, è stato diretto al cinema da Francesca Archibugi (Verso sera), Carlo Mazzacurati (Un’altra vita), Marco Risi (Il Branco), Ettore Scola (La cena), Renato De Maria (Paz).
Giorgio Tirabassi
Sparare ad Ardenzi?
intervista a cura di Tiziana Carpinelli
 Tiziana Carpinelli (TC): Siamo con Giorgio Tirabassi, attore di teatro, cinema e piccolo schermo. In qualità di giurato di Maremetraggio, nonché a sua volta autore e regista di un corto, volevo chiederle cosa le è parso di questa manifestazione e, anche se non ci può esprimere in dettaglio le sue impressioni finali, come le sembra, in generale, la qualità dei corti qui presenti.
Tiziana Carpinelli (TC): Siamo con Giorgio Tirabassi, attore di teatro, cinema e piccolo schermo. In qualità di giurato di Maremetraggio, nonché a sua volta autore e regista di un corto, volevo chiederle cosa le è parso di questa manifestazione e, anche se non ci può esprimere in dettaglio le sue impressioni finali, come le sembra, in generale, la qualità dei corti qui presenti.
Giorgio Tirabassi (GT): A me è sembrato che la qualità dei corti italiani, ad esempio, sia migliorata, cioè che essa sia salita ma, rispetto agli investimenti che fanno gli altri paesi sui cortometraggi, siamo comunque un po’ in ribasso, nel senso che alcuni corti danesi, o del nord Europa, ma poi anche inglesi o francesi, hanno un impiego di mezzi maggiore e questo può essere sicuramente un punto di favore, però è anche vero che nelle storie italiane c’è comunque un po’ del genio nazionale, qua e là; tuttavia non sono molto ottimista: speravo di vedere, devo ammetterlo, tutte cose belle, essendo questa una manifestazione di cortometraggio che hanno già vinto in Italia e all’estero. Pensavo che la qualità fosse migliore. Però va bene, va bene comunque, perché il corto è l’espressione che permette di cimentarsi a tutti, il lungo non è la stessa cosa. Io ho fatto un buon corto, ma penso…
TC: Col quale si è portato a casa numerosi premi.
GT: Sì, ne ho vinti tanti, però sai, il corto ha una dimensione che puoi controllare di più ed è appunto per questo che rimango un po’ deluso quando vedo dei tentativi di cortometraggio che non sono andati proprio a segno.
Questo un po’ dispiace perché una volta che uno, soprattutto un esordiente, accumula degli sforzi ingenti per fare un corto, penso che dovrebbeesserci almeno un po’ più di concentrazione su quello che riguarda il racconto: molto spesso si usa il cortometraggio per esercizio di stile, per “muovere la macchina da presa”, come si dice, anche senza una vera consapevolezza del termine.
Ma, quando nel cortometraggio – che può essere paragonato un po’ alla novella o al racconto breve e quindi ha una sua identità precisa – ci si trova davanti ad una storia o ad una piccola favola, ecco che, secondo me, il corto vive la sua condizione naturale e allora lì sono contento; voi avete chiesto il mio parere e io questo vi ho dato.
TC: So che da poco ha ultimato un lavoro con Tavarelli, regista presente a Maremetraggio: si tratta di Borsellino, lavoro in cui lei ha interpretato il ruolo principale. Nella sua dimensione di attore estremamente versatile – è stato diretto da Scola, Archibugi, Ponti – cosa ha rappresentato nella sua carriera interpretare un personaggio così importante.
GT: Un salto di qualità e di maturità, perché si tratta di un personaggio importantissimo, un personaggio nella memoria della gente, un uomo molto distante da me, un giudice, un uomo che ha vissuto diversi anni della sua vita con la consapevolezza di essere ucciso, e quindi, come esperienza, all’inizio ero molto, molto titubante; e poi, invece, la titubanza mia e l’incertezza di Tavarelli ha fatto sì che attraverso le parole di Borsellino, riuscissimo ad entrare in questo lavoro con un atteggiamento che, ad esempio, io non avevo mai avuto: e cioè proprio quello di entrare nella vita, nella mentalità di un personaggio simile, capire (come diceva lui) che la paura è in fondo solo un ostacolo e che la paura va superata col coraggio, altrimenti non si fa niente e nel suo caso era fondamentale far capire questa cosa. In una dimensione naturalmente ridotta mi sono ritrovato io a vivere quella paura, una paura d’attore: la paura di interpretare un personaggio difficile, distante da me.
Quindi ho capito che la mia paura era assolutamente zero rispetto a quella che dovevano invece superare gli agenti della scorta, i magistrati vicino a Borsellino, la famiglia: e così siamo partiti, abbiamo fatto questo film, secondo me molto bello.
Dal punto di vista della buona fede, sicuramente abbiamo dato il massimo, facendolo con un sentimento che, lo ripeto, non avevo mai provato e in virtù di ciò, a questo punto, spero che abbia un buon ascolto – ma non per vanità professionale, lo giuro – proprio perché è un progetto di impegno civile: l’ho detto già altre volte, spero che dopo il film i ragazzi a scuola facciano un tema su questi personaggi; non c’è solo Borsellino, c’è Falcone, i due erano anche amici, ci sono gli ufficiali dei carabinieri, il Cis, le persone della scorta. È stato un momento storico importante, molto recente e ho visto che sul testo di storia delle medie di mio figlio, c’è un paragrafetto su questo fatto, mentre alcuni giovani siciliani pensano che Borsellino sia soltanto il nome dell’aeroporto di Palermo. Quindi, forse è stato giusto farlo questo film ed è giusto non compiacersi nel dolore della retorica, cosa che noi abbiamo evitato fin dal primo momento.

TC: C’è stata una paura anche nei confronti dello sguardo dei familiari o c’è stato, in questo caso anche un rapporto di scambio e di collaborazione nel progetto?
GT: I familiari, per loro natura, non sono molto contenti di apparire, assolutamente. Nel nostro caso ci hanno seguito, hanno anche letto le frasi della sceneggiatura, ci siamo incontrati, ho conosciuto Manfredi e Fiametta, due dei figli di Borsellino. Loro ci hanno fatto capire di aver piacere che esca fuori un’immagine del padre anche dal punto di vista umano, ad esempio, poiché ciò corrisponde ad un accrescimento rispetto all’immagine soltanto del giudice e perché loro per primi sentono la necessità di parlare, dopo dodici anni, di questo fatto che sembrerebbe chiuso come un “normale fatto italiano” e che oramai siamo abituati a tenere lì. Solitamente si dice: “Sì, vabbè, è successo… e non si sa bene come”, ma qui si sa, è stato lo stesso Stato italiano.
E quindi è una delle pagine più brutte, anzi, più infami della storia italiana e quindi spero serva a qualcosa (questo lavoro), speriamo.
TC: Facciamo un passo indietro: da giudice a delinquente con Coatto unico. So che lei ha portato questo spettacolo nel carcere di Rebibbia e che è uscito anche in videocassetta con l’Espresso: cosa ha rappresentato, invece, questa esperienza d’attore rispetto a tutte le altre, specie in ambito teatrale?
GT: Anche lì si è trattato di una crescita, di un passo avanti. È stata fondamentale l’esperienza di lavorare con persone che hanno un punto di vista completamente diverso da tutti gli altri, perché non vivono la libertà e paradossalmente, dentro di loro, proprio in quel posto e dopo la condanna, avviene che ognuno capisca il meglio di se stesso: poi c’è il più volenteroso e il meno volenteroso, il più pigro e quello meno pigro, però sono persone che si trasformano e quindi hanno tutto il diritto ad essere in qualche modo ascoltate. Per carità, io non dico che non debbano stare là, hanno sbagliato, alcuni hanno fatto dei gravissimi reati, e quindi è giusto che siano lì per dieci, venti o trent’anni, dipende. Questo è un discorso di giustizia, puoi anche parlare della penitenza, della condanna: è un argomento complesso. Umanamente, ho accresciuto il mio bagaglio principalmente personale e poi anche professionale: il pubblico è il pubblico, però nel caso delle recite a Rebibbia è diverso perché non si tratta di un pubblico che va a teatro e quindi non c’è uno scambio alla pari, perciò se uno tenta una cosa raffinata è chiaro che qualcuno apprezza ma tanti altri magari no, non per questo però si deve scendere per forza alla volgarità o alla gag da avanspettacolo perché è un pubblico più intelligente e quindi elevando quel tipo di umorismo ad una cosa più concettuale si ottiene un bel risultato. Loro, ti assicuro, ragionano il quadruplo del tempo di noi, perché mentre noi abbiamo delle cose da fare, il tran-tran quotidiano, loro pensano e lavorano; perché, per fortuna, un carcere come Rebibbia, che è una struttura molto moderna in Europa, una delle più all’avanguardia, sono organizzate attività collettive. E lì pure suonano, hanno un gruppo che si chiama I presi per caso (ride, ndr), con i quali ho lavorato, ci siamo divertiti: loro hanno sempre voglia di fare, di apparire, di dimostrare che ora sono persone diverse e lo diventano davvero lì dentro, però poi il problema è quando escono e quindi capiamo che il sistema di rieducazione non dipende solo dal carcere, ma dipende dallo Stato: è sempre un discorso politico, sempre. Poi c’è chi questo discorso lo fa dichiaratamente e politicamente e c’è chi lo fa col teatro, chi scrivendo, chi facendo un quadro, insomma, verte tutto intorno al nocciolo politico.

TC: Lei è sicuramente un attore poliedrico, ma una costante di questi ultimi anni sembra essere il personaggio dell’ispettore capo Ardenzi di Distretto di polizia, in questo caso, si è in parte stancato di vestirne i panni?
GT: No, dei panni non mi sono stufato perché la lunga serie permette di avere un personaggio a tutto tondo, veramente a 360º, mentre invece in alcuni film il personaggio ha precise caratteristiche in un arco narrativo.
In Distretto c’è veramente il modo di vedere crescere il personaggio: un esempio è questa figlia dell’ispettore che nella fiction, adesso, sarà grandicella e comincerà ad avere cinque anni (e già ci si può porre ad un livello comunicativo diverso).
Comunque tutti noi siamo cresciuti: guardo le repliche e mi vedo con la faccia da ragazzino e poi altre, più recenti e capisco che il tempo è passato.
Quello di Distretto è stato sempre, ed è ancora, un ottimo gruppo; poi, sai, è un lavoro di dieci mesi, questo è il problema, il problema è soltanto questo: che fare Distretto di polizia significa fermarsi – o più che fermarsi, rimanere a lavorare solo su questa fiction – per dieci mesi e non è più possibile fare altro e quindi, sì, c’è un po’ questa paura della stanchezza, però ti dico anche che io adesso devo cominciare ad ottobre e sono contento di rivedere tutti anche perché ho fatto per un anno Borsellino, ho ripreso lo spettacolo a teatro, ho fatto altre cose…
C’è anche bisogno di questo, del lavoro alternativo, perché altrimenti si riduce veramente tutto al cartellino: noi lavoriamo tutti i giorni per 10 mesi e non è che stiamo al ministero, c’abbiamo delle scene da girare; è il lavoro d’attore: è più faticoso star in miniera a spaccar carbone – questo è sicuro – però anche lì c’è una stanchezza. Noi lavoriamo molto sull’emotività, sull’entusiasmo, sui dialoghi che, sai, più o meno sono sempre del tipo: “Abbiamo rilevato tracce di…” e ogni tanto non ce la fai più, perciò, in questa situazione funziona invece il nostro rapporto e ce lo portiamo, appunto, un po’ sul set, così, anche quando c’è il ciak, c’è ancora un attimo di Giorgio:anzi c’è molto di noi, ed è poi proprio così che escono i personaggi veri e diretti.
Bisogna ovviamente affinare un po’ la tecnica perché non è una cosa che avviene automaticamente, però si lavora con un po’ di divertimento, con un minimo di gioco infantile, il che è vitale: sennò ci sono quelli che fanno questo lavoro per dieci mesi e c’hanno la faccia che diventa come il costume, purtroppo è così; Noi ancora ci divertiamo, per l’ultima volta, però: questo è l’ultimo anno, perlomeno per me, sì, me sparerò su un ginocchio e me faccio trasferì! No, credo davvero che sia l’ultimo, quasi sicuramente.
TC: E il teatro? Nove anni alla scuola di Proietti, cosa rappresenta il teatro, che poi è la vita del recitare, per un attore.
GT: Eh, sono i primi passi, quelli importanti, perché è fatto tutto all’esterno. Chi comincia a fare l’attore adesso (oppure anche in altri momenti) direttamente col cinema o anche con la televisione – e quindi con una recitazione più attenta – lavora dentro, psicologicamente, nel teatro sì, c’è anche questo, però la recitazione tende ad uscire, e questo è un modo diverso di lavorare.
Muovere i primi passi in quel modo significa capire tanto, non so spiegarlo, c’è chi lo sa fare meglio di me, però posso dire che è veramente fondamentale: non è un luogo comune, è basilare perché poi si capisce davvero come lavorare quando si va su un set e ti fanno un primo piano, e tu magari non sai neanche che cos’è se non quando poi vai al cinema. Quando ho cominciato io era così: non c’erano le immagini sul monitor, o cose simili, c’era solo l’uscita al cinema, lì ti vedevi e ti dicevi: “Forse qui ho fatto troppo”. Adesso ovviamente è diverso, anche con la possibilità delle telecamere: è tutto più facile, c’è l’abitudine alla propria immagine, e quindi chi comincia in quel modo può avere ovviamente dei problemi e, infatti, ciò avviene per alcuni giovani di queste soap, di queste lunghe serie. Si vede subito chi viene dal teatro e chi ha scelto invece un'altra strada: non so come dire, io credo che oggi il lavoro di un attore sia associato al successo, così come quello di un calciatore è associato al successo e ai soldi, e quello del politico è associato al potere… Una volta il lavoro dell’attore era associato alla sofferenza. Quando io andavo in teatro, si parlava del teatro come sofferenza o sacrificio – è una esagerazione, certo – però nasce da quei sentimenti lì. Il cinema non è soltanto la fiction, non è Le ragazze di Piazza di Spagna, se così fosse diventerebbe un messaggio controproducente; adesso sono andato su un altro binario e mi sono un po’ perso però, sì, credo che purtroppo ora si arrivi al lavoro dell’attore soltanto perché una ragazza è bionda, gli occhi azzurri, come te, molto carina, e quindi perché tu puoi pensarla così? Sicuramente ti è passato per la testa, qua e là, il pensiero di fare l’attrice e forse lo farai anche, però – non che tu non lo debba fare, eh? – purtroppo è diventata una visione comune, di massa, come quella del più simpatico del gruppo che va allo Zelig. Ma il cabaret è una cosa, non è solo quello che vediamo noi in televisione: per carità, io non voglio dire che Zelig sia sbagliato, assolutamente. Zelig tira fuori dei comici molto bravi, è una formula importante perché c’è l’umorismo del nord ed è fondamentale che ci siano più sonorità possibili associate all’umorismo. Sono assolutamente convinto che sia giusto, però ho l’impressione che molti giovani vedano la strada un po’ troppo facile e rimangono delusi quando poi si accorgono che non li chiamano oppure che fanno un film e poi la cosa finisce là, mentre c’è gente che si prepara seriamente e magari non lavora, perché i teatri italiani e i teatrini off sono pieni di attori di ottimo talento. Ci vuole fortuna.

TC: Ultima domanda, quali sono i suoi progetti futuri?
GT: Arrivi in un momento appropriato, per questo non posso risponderti, e quindi ti dico semplicemente che comincerò a ottobre Distretto di polizia; però parallelamente intraprenderò un progetto di cui, al momento, preferirei non dire niente a nessuno.
_____________________________
Giorgio Tirabassi, approdato alla scuola di Gigi Proietti nel 1982, dove ha studiato per 9 anni, è stato diretto al cinema da Francesca Archibugi (Verso sera), Carlo Mazzacurati (Un'altra vita), Marco Risi (Il Branco), Ettore Scola (La cena), Renato De Maria (Paz).
Nel 2001 ha firmato come regista il cortometraggio Non dire gatto, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali tra cui quello del Festival di Montpellier.
Nella fiction televisiva Distretto di Polizia è l'ispettore capo Roberto Ardenzi.
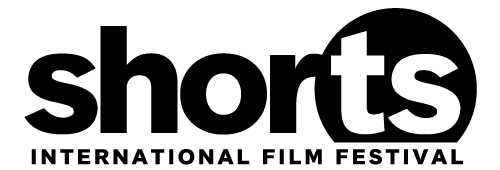

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!